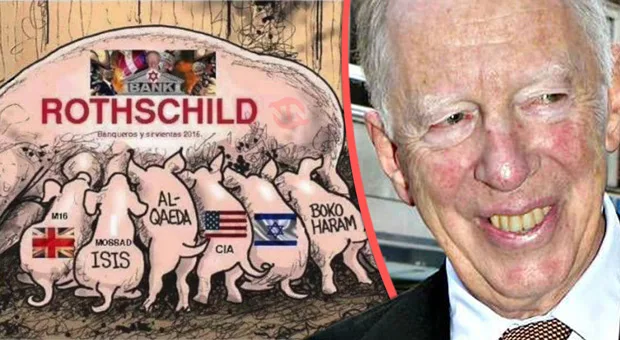USA: Le Black Panther sono ancora in prigione dopo 46 anni, saranno mai liberate?
Markus
ED PILKINGTON
theguardian.com
Antoinette Russell ricorda come se fosse ieri la prima volta che le hanno fatto credere che avrebbe potuto finalmente incontrare suo padre da uomo libero. L’aveva chiamata da un telefono della prigione, con la voce tremante per l’eccitazione, e le aveva detto: “torno a casa!”
Questo succedeva 17 anni fa. Da allora, ogni due anni, deve sottostare alla medesima tortura. “[Ogni volta] chiama dicendo la stessa cosa: torno a casa,” mi dice, mentre la intervisto nella sua casa di Montgomery, Alabama.
Si potrebbe provare anche a misurare il dolore insopportabile che attanaglia queste due donne, ma le somiglianze finiscono qui: non hanno nulla in comune quando si tratta di decidere quale dovrebbe essere il destino di quest’uomo.
La Russell spera che a suo padre venga concessa la libertà. La Piagentini prega che possa marcire nella sua cella, per sempre.
L’oggetto delle attenzioni delle due donne è il padre di Antoinette Russell, Jalil Muntaqim che, nel carcere di massima sicurezza, è conosciuto con il suo nome di battesimo, Anthony Bottom, numero di matricola 77A4283.
 Jalil Muntaquim, che ha trascorso gli ultimi 47 anni in prigione.
Jalil Muntaquim, che ha trascorso gli ultimi 47 anni in prigione.
Ex membro del partito delle Black Panther e del suo braccio armato clandestino, il Black Liberation Army, ha trascorso quasi 47 anni in prigione per il ruolo avuto nell’omicidio di due agenti di polizia a New York City, nel 1971. Uno di questi agenti era Joseph Piagentini, il marito di Diane.
Muntaqim è uno dei 19 estremisti di colore, comprese due donne, ancora in prigione dopo più di 40 anni dall’arresto per atti di violenza commessi durante la loro lotta di liberazione. L’anno prossimo, il condannato che sta scontando la pena da più tempo, Romaine “Chip” Fitzgerald, sarà stato incarcerato per mezzo secolo. Il più anziano, Sundiata Acoli, ha 81 anni.
Dal 2000, altri dieci estremisti sono morti in prigione per malattia.
I 19 estremisti attualmente incarcerati facevano tutti parte del movimento rivoluzionario delle Black Panther. Hanno combattuto per il Potere Nero, sono stati condannati per aver ucciso in suo nome, anche se molti di loro si professano innocenti, e oggi sono ancora in prigione per causa sua.
Mentre invecchiano, e la pena si allunga, lo scontro etico su che cosa fare di questi uomini e donne si fa sempre più intenso. La settimana scorsa si era verificato uno sviluppo inatteso, che avevamo segnalato in anteprima; Robert Seth Hayes, ex membro, come Muntaqim, delle Black Panther e del Black Liberation Army, era stato rilasciato, all’età di 69 anni, dallo stesso carcere di massima sicurezza di New York.
Hayes aveva trascorso 45 anni in prigione per l’omicidio di un agente della New York City Transit Police, Sidney Thompson, durante uno scontro avvenuto nella stazione del Bronx nel 1973. Era stato condannato ad una pena variabile da 25 anni all’ergastolo.
Era diventato idoneo alla richiesta di libertà vigilata nel 1998, ma, ogni due anni, si era sentito ripetere sempre la stessa cosa: nonostante fosse un detenuto modello, agli occhi della commissione per la libertà vigilata rimaneva sempre una minaccia per la società. Solo all’undicesimo tentativo, 20 anni dopo, con la salute ormai in rapido declino, era riuscito a convincerli di essere degno della riabilitazione.
Il rilascio di Hayes alza ancora di più la posta in gioco, perché costringe le autorità di New York e quelle di tutto il resto del paese a porsi la domanda cruciale: esiste qualcosa di simile alla riabilitazione per chi ha ucciso agenti di polizia in nome della causa rivoluzionaria del Potere Nero? Bisogna rinunciare alla politica della libertà condizionata basata sul merito? O il sistema giudiziario degli Stati Uniti li ha selezionati per una condanna all’ergastolo estremamente punitiva perché li ritiene prigionieri politici, proprio come si autodefiniscono quegli uomini e quelle donne?
Negli ultimi due anni ho intervistato otto estremisti neri che avevano tutti trascorso lunghi periodi di detenzione. Attraverso visite in carcere, lettere ed email, gli attivisti mi avevano raccontato storie sorprendentemente simili, di come avessero trascorso quasi tutta la loro vita in cella e del lungo cammino verso una libertà che non arriva mai. Sei di essi sono fra i diciannove che, attualmente, sono ancora in carcere.
Uno degli aspetti che colpisce di più nelle loro storie è la costante passione per la causa dell’emancipazione dei neri. La loro convinzione sul valore di questa lotta contro l’ingiustizia è pura e adamantina.
Prendete Jalil Muntaqim, 66 anni. Secondo i termini della sua condanna per duplice omicidio, ha ottenuto il diritto ad essere valutato, ogni due anni, per la libertà condizionata fin dal 2002. Ad agosto ripartirà tutta la trafila: comparirà davanti alla commissione per la libertà vigilata e perorerà la causa del suo rilascio per la nona volta.
Alla commisione parlerà del suo rimorso nei confronti delle famiglie degli agenti uccisi. Parlerà del rimorso che prova verso la sua stessa famiglia, da cui manca ormai da 46 anni.
Ma non rinuncerà al suo credo politico.
Le Black Panther, che ufficialmente hanno cessato di esistere nel 1982, sono ritornate nuovamente di moda, postume, negli ultimi due anni. La scena di apertura del film di successo “Black Panther” è stata girata in un campo di pallaccanestro di Oakland, un preciso riferimento al luogo dove era stato fondato il partito nel 1966. La cantante Beyoncé aveva stupito l’America quando, nello spettacolo dell’intermezzo del Super Bowl del 2016, aveva reso omaggio alle Black Panther con un’esibizione comprendente giacche di pelle, berretti e pugni alzati.
Dietro questa parvenza di interesse popolare per le Black Panther, non esiste in pratica un dibattito pubblico su questa rivolta degli anni ‘70 e su quello che ne è seguito. Assai scarsa è la comprensione del pubblico su come avessero fatto le Black Panther, originarie di Oakland, ad avere 70 sezioni in tutti gli Stati Uniti, di come avessero affrontato a viso aperto la brutalità poliziesca, tipica dei centri urbani, nei confronti degli Afro-Americani, su come avessero sviluppato un sofisticato programma di aiuti sociali che includeva mense per i poveri ed anche scuole elementari, e come tutto questo avesse scatenato la feroce repressione del governo federale e dell’FBI, che aveva portato a numerosi conflitti a fuoco, incursioni, intercettazioni illegali, gioco sporco e, infine, allo scioglimento del partito nel 1982.
Ancora meno si sa dei molti attivisti delle Black Panther che erano stati imprigionati.
In breve, adesso potrà anche essere di moda la giacchetta di pelle delle Black Panther, ma c’è veramente uno scarsissimo interesse per le uniformi da carcerato degli ex-attivisti ancora dietro le sbarre.
 Le Black Panther manifestano davanti al tribunale di New York City nel 1969.
Le Black Panther manifestano davanti al tribunale di New York City nel 1969.
Il viaggio che mi aveva letteralmente immerso nelle vite delle ex-Black Panther in carcere era iniziato nel 2015 con Albert Woodfox, un membro del cosiddetto Angola Three che, all’epoca, deteneva il primato di essere il prigioniero americano ad aver trascorso più tempo in cella d’isolamento. E’ rimasto in segregazione cellulare, quasi senza interruzioni, per 43 anni.
Insieme ad un suo compagno, Herman Wallace, Woodfox aveva fondato una sezione delle Black Panther nell’Angola, il famoso carcere di massima sicurezza in Louisiana, costruito sul terreno di una vecchia piantagione di cotone. Il nome ricorda la nazione africana da cui i proprietari della piantagione facevano arrivare gli schiavi.
Quando Woodfox era stato mandato all’Angola per rapina, nel 1971, la prigione era completamente segregata, con un’ala per i detenuti bianchi ed una separata per quelli afro-americani. I secondini erano esclusivamente bianchi.
Fulgido esempio del legame che unisce la schiavitù e l’incarcerazione di massa dell’era moderna, i prigionieri di colore erano utilizzati come forza lavoro a basso costo. Ogni giono, i detenuti di colore venivano raggruppati, incatenati e portati nei campi intorno al penitenziario, gli stessi campi che un tempo erano appartenuti alla piantagione, e fatti lavorare sotto il sole cocente.
A raccogliere cotone.
Woodfox e Wallace avevano iniziato, tramite la sezione delle Black Panther, ad organizzare gli altri detenuti di colore per indurli a protestare contro questa moderna forma di schiavitù. La cosa non era piaciuta alle autorità della prigione.
Un anno dopo, entrambi erano stati accusati dell’omicidio di un agente di custodia di nome Brent Miller, pugnalato a morte durante una rivolta carceraria. Sulla scena del delitto era stata raccolta una notevole quantità di prove, ma nessuna che potesse incriminarli, compresa un’impronta digitale insanguinata su un muro.
Nonostante ciò, erano stati giudicati colpevoli da una giuria di soli bianchi e condannati all’ergastolo, senza possibilità di libertà vigilata. Subito dopo la sentenza, Woodfox e Wallace erano stati messi in cella di isolamento, dove sarebbero rimasti per altri 40 anni.
Le dichiarazioni rilasciate nel corso degli anni dalle autorità carcerarie dell’Angola avevano chiarito le ragioni di questo trattamento eccezionalmente severo. L’allora direttore dell’Angola, Burl Cain, aveva detto, nel 1995, che aveva posto Woodfox in isolamento perché “stava ancora cercando di diffondere l’ideologia delle Black Panther.” Cain aveva aggiunto che non aveva voluto che il prigioniero fraternizzasse con gli altri “perché avrebbe arruolato i nuovi, giovani detenuti.”
Nel novembre del 2015, subito prima che gli fosse finalmente concessa, all’età di 69 anni, la possibilità di uscire come uomo libero, Woodfox mi aveva scritto. Nella lettera mi descriveva cosa volesse dire passare 43 anni di vita in una cella di 1,8 x 2,7 metri, con solo un giaciglio di cemento, un gabinetto e un lavandino, con una feritoia nella porta metallica in cui far passare il cibo.
Mentre Woodfox e Wallace passavano gli anni in isolamento nell’Angola, migliaia di altri giovani afro-americani entravano a far parte del partito delle Black Panther ad Oakland, Los Angeles, Chicago, New York e in tutti gli Stati Uniti. Anche se il partito era stato fondato da due uomini, Huey Newton e Bobby Seale ed aveva un taglio militare che potremmo definire maschilista, numerosi posti di responsabilità erano stati occupati anche dalle donne.
Fra di loro vi erano Afeni Shakur, madre del rapper Tupac Shakur, Elaine Brown, che sarebbe diventata capo del partito dopo la fuga a Cuba di Newton; Assata Shakur, nota come Joanne Chesimard, una leader del Black Liberation Army, anch’essa riparata a Cuba, dove vive tutt’ora in esilio, ancora sulla lista dei terroristi più ricercati dall’FBI.
Il movimento, contrariamente alla sua fama di violenza, dedicava la maggior parte del tempo al lavoro di comunità. Forniva colazioni gratuite ai bambini poveri dei quartieri neri, allestiva scuole e ambulatori medici per chi non poteva accedere al sistema sanitario e pubblicava un suo proprio quotidiano, il Black Panther, al costo di 10 cent., con una tiratura settimanale che era arrivata, nei periodi di punta, a 250.000 copie.
In contrasto con i toni misurati del movimento per i diritti civili di Martin Luther King, le Black Panther si consideravano allineate ai gruppi internazionali rivoluzionari dell’Angola, del Mozambico e del Vietnam. Alle nuove reclute, conosciute come PITS (Panthers-in-Training), veniva fatto studiare il “Libretto Rosso” di Mao e “I dannati della Terra” di Frantz Fanon.
 Membri del partito delle Pantere Nere distribuiscono gratuitamente abiti alla popolazione di New Haven, Connecticut, 1969.
Membri del partito delle Pantere Nere distribuiscono gratuitamente abiti alla popolazione di New Haven, Connecticut, 1969.
Nell’ottobre del 1966, Newton aveva riassunto gli obbiettivi del partito in un programma di dieci punti. Comprendeva un appello contro la brutalità della polizia, non dissimile da quanto chiede oggi Black Lives Matter, una istanza per la riforma del sistema giudiziario, che potrebbe benissimo essere quella dell’American Civil Liberties Union, e una richiesta per la piena occupazione, per case decenti e per un buon sistema scolastico che sembra uscita dalla bocca di Bernie Sanders.
A queste richieste relativamente tradizionali era stato sovrapposto un forte sentimento di militanza nera, in contrasto con l’approccio moderato di King o con la radicata politica progressista di oggi. “Vogliamo porre fine alla rapina capitalistica della nostra Comunità Nera”, si leggeva al punto n° 3 e si continuava chiedendo un risarcimento per la schiavitù subita, consistente in due muli e 40 acri di terreno, un chiaro riferimento alla promessa, non mantenuta, fatta dal generale William Sherman di liberare gli schiavi alla fine della guerra civile.
Poi c’era l’enfasi sul militarismo e sulla lotta armata. Anche la struttura stessa dell’organizzazione era una provocazione, configurare il partito come uno stato all’interno dello stato.
 Huey Newton parla alla convention per la fondazione del Partito Popolare Rivoluzionario nel 1970.
Huey Newton parla alla convention per la fondazione del Partito Popolare Rivoluzionario nel 1970.
Come dice Mumia Abu-Jamal, una ex-Black Panther, incarcerato per 37 anni per l’omicidio di un agente di polizia di Filadelfia, “Il partito delle Black Panther si comportava come uno stato-ombra, con i suoi ministri, il suo personale in uniforme e i suoi soldati, in feroce opposizione al governo degli Stati Uniti.”
Una delle prime attività del partito era stata la “vigilanza sulla polizia”, durante la quale i suoi membri monitoravano l’attività delle forze dell’ordine nelle vie di Oakland, in un periodo in cui gli attacchi della polizia alla popolazione nera erano un fatto quotidiano. E’ difficile che una cosa del genere possa succedere al giorno d’oggi, ma, allora, quando vedevano agenti di polizia fermare e perquisire giovani Afro-Americani, le Black Panther si avvicinavano e osservavano la scena, facendo volontariamente intravedere le pistole che portavano alla cintura.
Newton aveva studiato le leggi californiane sul possesso delle armi e sapeva che girare armati in pubblico, senza nasconderlo, alla fine degli anni ‘60 era legale. I legislatori dello stato avevano risposto nel 1967 proibendo il “porto libero” e, per celebrare l’evento, più di 20 Black Panther erano entrate impugnando le armi nel Campidoglio di Sacramento durante il dibattito.
La minaccia di una insurrezione armata dei rivoluzionari neri aveva scatenato una dura rappresaglia da parte del governo degli Stati Uniti.
L’allora direttore dell’FBI, J. Edgar Hoover, aveva giurato di spezzare il partito delle Black Panther, che aveva definito “la più grande minaccia alla sicurezza interna della nazione.”
Il programma di sorveglianza segreto Cointelpro era così stato focalizzato sulle Black Panther e tutte le enormi risorse dell’FBI mobilitate contro di loro. In breve tempo, il partito era stato riempito di informatori e di agenti provocatori, che diffondevano false informazioni e seminavano zizzania fra i ranghi.
Gli scontri violenti con la polizia erano diventati frequenti: le forze dell’ordine e i media li chiamavano “Shoot-outs.” Per le Black Panther erano invece “Shoot-ins,” intendendo con questo termine che gli scontri venivano istigati dalle autorità e che facevano parte dei trucchi sporchi del Cointelpro.
Secondo le stesse Black Panther, fra il 1968 e il 1970 si erano verificati 28 scontri armati con la polizia locale o con gli agenti dell’FBI, in cui 19 dei loro avevano perso la vita. Per contro, le forze di polizie consideravano il Black Liberation Army, l’ala clandestina del partito, fondata nel 1970, responsabile dell’omicidio di almeno 13 agenti di polizia.
Era in questo ambiente che Jalil Muntaqim, allora conosciuto con il nome di Anthony Bottom, si era gettato, anima e corpo, quando aveva solo 15 anni. Non era di certo il candidato ideale per la carriera di rivoluzionario nero, dal momento che proveniva da una famiglia benestante di San Jose, con entrambi i genitori che lavoravano e la piscina in giardino.
La madre aveva insegnato ai figli le danze africane e dava molta importanza alla discendenza familiare. Muntaqim era stato attratto da King e dal movimento per i diritti civili, ma si era subito messo alla ricerca di qualcosa di più radicale. Un compagno di scuola era entrato a far parte delle Black Panther e il movimento lo aveva attirato.
Muntaqim aveva iniziato vendendo il quotidiano delle Black Panthere dando una mano nelle mense gratuite. Da qui era stato assegnato alla scorta dei leaders di alto profilo che venivano in visita ad Oakland.
Nel 1970, il Black Liberation Army (BLA) costituiva la falange armata del movimento. In quel periodo e fino alla messa al bando ufficiale del partito delle Black Panther, nel 1982, il BLA era stato implicato in una lunga serie di rapine in banca, attentati dinamitardi, evasioni e omicidi di agenti di polizia.
Muntaqim si era arruolato a 18 anni ed era entrato in clandestinità. “Continuavo ad avere una vita pubblica come assistente sociale al Dipartimento per la Disoccupazione della California,” ha spiegato nell’intervista. “Ma c’era un altro aspetto della mia vita: la mia attività clandestina nel Black Liberation Army.”
Il 21 maggio 1971, due agenti di polizia di New York, Joseph Piagentini, bianco, e Waverly Jones, di colore, erano di pattuglia nella 159° Strada, ad Harlem. Erano stati chiamati per quella che sembrava una lite familiare.
 Gli agenti della polizia di New York, Joseph Piagentini e Waverly Jones, uccisi da Herman Bell ed altri ad Harlem nel 1971.
Gli agenti della polizia di New York, Joseph Piagentini e Waverly Jones, uccisi da Herman Bell ed altri ad Harlem nel 1971.
Joseph Piagentini e Waverly Jones stavano ritornando all’auto di pattuglia, circa alle 22, quando erano stati attaccati alle spalle da tre uomini armati. Jones era morto subito, colpito da un proiettile alla nuca; Piagentini, secondo gli inquirenti era stato colpito 13 volte.
Nel giro di pochi giorni erano stati arrestati tre membri del BLA, Muntaqim, Herman Bell e Albert “Nuh” Washington. Muntaqin e Bell erano stati entrambi condannati ad un periodo di detenzione non inferiore a 25 anni, Washington è morto in prigione nel 2000.
Tre mesi fa si è verificato un evento raro: Herman Bell, 70 anni di età, è stato rilasciato. Era stata la sua ottava apparizione di fronte alla commissione, dopo 45 anni dietro le sbarre.
Bell era apparso alla commissione per la libertà vigilata come qualcuno che, dopo quasi mezzo secolo, era diventato un detenuto modello e provava un sincero rimorso per i suoi omicidi. Una parte della decisione del comitato era dovuta al fatto che, quando era stato interrogato nel mese di marzo, Bell aveva espresso il proprio disgusto per quello che aveva commesso nel 1971.
La decisione della commissione ha scatenato un vespaio di proteste da parte dei sindacati locali di polizia, dei media e degli esponenti politici. La New York Patrolmen’s Benevolent Association ha dichiarato di essere “disgustata, offesa ed estremamente adirata” ed ha definito Bell “un terrorista locale.”
 Diane Piagentini nella sua casa.
Diane Piagentini nella sua casa.
Una tale reazione al rilascio sulla parola del suo coimputato fa capire la grande sfida che Muntaqim si troverà a dover affrontare quando si troverà di fronte alla commissione, nel mese di agosto.
A suo favore gioca il comportamento da detenuto modello che ha tenuto per anni. La stessa cosa si può dire riguardo alla maturazione del suo carattere, dai giorni della sua attività rivoluzionaria in gioventù.
Mi ha anche detto che si è evoluto anche il suo concetto di lotta armata. Secondo lui la priorità non dev’essere l’insurrezione, ma la costruzione di “un movimento popolare di massa. Preferisco dire che siamo armati di idee, di comprensione e di amore per il nostro popolo.”
Come la maggior parte degli altri diciannove estremisti di colore attualmente detenuti, si considera un prigioniero politico e afferma che la sua militanza nelle Black Panther non era dovuta all’autoesaltazione o al profitto personale. Nel 1998, aveva fondato il Movimento Jericho, che si batte per tutti quelli che vengono definiti “prigionieri politici e prigionieri di guerra.”
Il conflitto che attanaglia Muntaqin, il suo ardente desiderio di libertà opposto alla volontà di non rinunciare al proprio credo politico, da lui ritenuto nobile, è condiviso dalla maggior parte degli altri diciannove estremisti di colore che ancora si trovano dietro le sbarre.
Di questi diciannove, sedici erano stati condannati per l’assassinio di agenti di polizia o di altri funzionari in divisa. Molti di loro dicono di essere innocenti e la maggior parte sostiene di essere stata appositamente selezionata per subire la collera dello stato americano.
Che cos’ha in comune il loro trattamento con quello riservato agli altri detenuti colpevoli dell’assassinio di agenti delle forze dell’ordine nel corso di reati comuni, come, per esempio, le rapine? Un confronto significativo è impossibile, vista la natura decentrata del sistema giudiziario americano. Come sottolinea il Sentencing Project: “I 50 stati usano metodiche differenti nel comminare le pene. Dal momento che i casi politici sono relativamente pochi, è difficile arrivare a delle conclusioni concrete.”
Le comparazioni internazionali sono comunque istruttive. In confronto al trattamento carcerario dei rivoluzionari armati che si erano macchiati di crimini violenti in Europa negli anni ‘70, gli Stati Uniti sembrano essere molto meno aperti al concetto di riabilitazione.
Prendete la Banda Baader-Meinhof della Germania Occidentale, il gruppo di estrema sinistra fondato nel 1970, conosciuto anche come Rote Armee Fraktion. Imgard Moller, che era stata arrestata nel 1972 per un attentato dinamitardo che aveva ferito diversi agenti di polizia e ucciso tre soldati, è stata rilasciata nel 1995. Anche Brigitte Mohnhaupt, che era stata catturata nel 1982 e condannata a cinque ergastoli per la sua partecipazione a numerosi omicidi, è stata rilasciata nel 2007, dopo 24 anni di detenzione, e da allora vive in modo anonimo, senza più obblighi verso la giustizia.
Chi si batte per la riforma del sistema giudiziario americano sostiene che i lunghissimi periodi di detenzione comminati agli estremisti del potere nero devono essere visti nel contesto dell’eccezionalmente severo concetto di punizione dell’America, specialmente nei confronti della gente di colore. Gli Stati Uniti, con il 5% della popolazione mondiale, ospitano il 25% dei detenuti di tutto il mondo, con più di due milioni di persone incarcerate. In America, una persona di colore ha una probabilità sei volte maggiore di essere imprigionata rispetto ad un bianco. Nel 2016, secondo il Pew Research Center, la popolazione di colore rappresentava solo il 12% della popolazione adulta degli Stati Uniti, ma il 33% di quella carceraria. La popolazione bianca, al contrario, costituiva il 64% degli adulti americani, ma contribuiva a quella carceraria solo per il 30%.
La folta rappresentanza dei detenuti americani sta anche invecchiando rapidamente. Secondo alcune stime, nel 2030 le persone di 50 o più anni costituiranno un terzo di tutta la popolazione carceraria dagli Stati Uniti.
“E’ un problema di giustizia e riabilitazione,” dice Robert Boyle, che ha rappresentato sei ex-Black Panther, compreso Herman Bell, durante le valutazioni per la concessione della libertà condizionata. Si è rifiutato di discutere il caso di Bell, ma, parlando in generale, ha detto: “E’ un problema che dobbiamo affrontare, in questo paese e in tutto il mondo. E’ forse l’unica forma di giustizia uccidere o far morire in carcere il colpevole dell’assassinio di un agente di polizia o di qualche altro efferato crimine, anche quando non rappresenta più nessun pericolo per il pubblico?”
La scrittrice ed attivista Angela Davis, che era stata definita dal Presidente Richard Nixon una “pericolosa terrorista” dopo essere stata accusata (e poi assolta) di complicità nel rapimento di un giudice, mi ha detto che gli attivisti neri attualmente detenuti sono in un vicolo cieco. O si pentono di crimini che non hanno mai commesso, o moriranno nelle loro celle.
La Davis mi ha detto che i militanti sono stati anche sottoposti a pressioni per indurli a tradire il proprio credo politico. “Dovrebbero denunciare un partito che è stato il precursore del Black Lives Matter di oggi.”
Quando Jalil Muntaqim, fra qualche giorno, si troverà di fronte alla commissione per la libertà vigilata, è quasi certo che si sentirà chiedere spiegazioni su quello che era successo nella notte del 21 maggio 1971. Io, quando l’ho incontrato in prigione, gli ho rivolto la stessa domanda.
E’ tuttora dell’opinione che il suo caso non sia stato trattato nella maniera giusta. In base alle leggi sulla libertà di informazione ha potuto avere accesso a documenti che mostrano come Nixon ed Hoover avessero manifestato un interesse personale per la caccia ai responsabili dell’omicidio (da essi chiamato “Newkill”, New York killings) dei due agenti di polizia di New York. Quella insolita collaborazione fra Casa Bianca, FBI e investigatori locali non era mai stata comunicata, come avrebbe dovuto essere, agli avvocati difensori di Muntaqim durante il processo.
Muntaquim è anche del parere che quei documenti indichino palesi discrepanze nelle prove fornite alla giuria sulle le armi usate negli omicidi.
Sta forse dicendo che ai più alti livelli c’era il desiderio di addossargli gli omicidi di Piagentini e Jones?
Nonostante le ingiustizie che dice di aver sofferto, Montaquim non si proclama innocente. Fin dal 2006 ha continuato a ripetere ogni due anni alla commissione per la libertà vigilata che si assume in pieno la responsabilità degli omicidi e che “mi pento moltissimo per aver causato quelle due tragiche morti.”
La Piagentini non vuole neanche sentirne parlare. Secondo lei, Muntaqim “non ha mai ammesso di avere ucciso mio marito. Non ha mai mostrato rimorso. Tutto quello che fa, lo fa per cercare di uscire di prigione.”
Sulla morte di suo marito, quasi 47 anni fa, dice: “Il dolore non passa mai. Sapere che non farà mai più ritorno a casa, non me ne fa provare di meno. Non voleva lasciarmi quella notte, e perciò è come se non mi avesse mai lasciato.”
 Antoinette Russell
Antoinette Russell
In Alabama, Antoinette Russell non può fare a meno di essere sui carboni ardenti per l’imminente comparsa del padre davanti alla commissione per la libertà vigilata, nonostante tutti i suoi sforzi per non farsi coinvolgere dal processo. E’ la sua unica figlia, nata sei mesi dopo il suo arresto. Pensa di averlo visto, di persona, non più di una decina di volte in tutta la sua vita, sempre al di là di una barriera di filo spinato percorso da corrente elettrica.
Ripensa alla sua vita e si chiede come sarebbe stata se il padre non fosse entrato a far parte delle Black Panther. “Crescere senza mio papà ha avuto un sacco di alti e bassi, più bassi che alti,” mi dice.
Nel corso degli anni lo ha perdonato. Ma il desiderio di riaverlo a casa non ha fatto altro che crescere.
Ed Pilkington
Fonte: theguardian.com
Link: https://www.theguardian.com/us-news/2018/jul/30/black-panthers-prison-interviews-african-american-activism
30.07.2018
Tradotto da Markus per comedonchisciotte.org

Markus
ED PILKINGTON
theguardian.com
Antoinette Russell ricorda come se fosse ieri la prima volta che le hanno fatto credere che avrebbe potuto finalmente incontrare suo padre da uomo libero. L’aveva chiamata da un telefono della prigione, con la voce tremante per l’eccitazione, e le aveva detto: “torno a casa!”
Questo succedeva 17 anni fa. Da allora, ogni due anni, deve sottostare alla medesima tortura. “[Ogni volta] chiama dicendo la stessa cosa: torno a casa,” mi dice, mentre la intervisto nella sua casa di Montgomery, Alabama.
“Sono arrivata al punto che gli dico: papà, non voglio sentirti più. Ogni volta mi faccio delle illusioni pensando che tu verrai rilasciato, e poi non lo sei. Ogni volta mi sembra di morire.”
A millecinquecento chilometri di distanza, a Deer Park, Long Island, Diane Piagentini è intrappolata esattamente nello stesso, drammatico, corso e ricorso degli eventi, collegato alla medesima persona. “Ogni due anni ti strappano il cerotto che avevi sul cuore e ti tocca ricordare tutto quello che era successo e riviverlo in continuazione,” mi dice.
Si potrebbe provare anche a misurare il dolore insopportabile che attanaglia queste due donne, ma le somiglianze finiscono qui: non hanno nulla in comune quando si tratta di decidere quale dovrebbe essere il destino di quest’uomo.
La Russell spera che a suo padre venga concessa la libertà. La Piagentini prega che possa marcire nella sua cella, per sempre.
“Deve rimanere in cella per il resto della sua vita. Quando ci si macchia di un crimine efferato come quello, si merita solo la pena di morte.”
L’oggetto delle attenzioni delle due donne è il padre di Antoinette Russell, Jalil Muntaqim che, nel carcere di massima sicurezza, è conosciuto con il suo nome di battesimo, Anthony Bottom, numero di matricola 77A4283.
 Jalil Muntaquim, che ha trascorso gli ultimi 47 anni in prigione.
Jalil Muntaquim, che ha trascorso gli ultimi 47 anni in prigione.Ex membro del partito delle Black Panther e del suo braccio armato clandestino, il Black Liberation Army, ha trascorso quasi 47 anni in prigione per il ruolo avuto nell’omicidio di due agenti di polizia a New York City, nel 1971. Uno di questi agenti era Joseph Piagentini, il marito di Diane.
Muntaqim è uno dei 19 estremisti di colore, comprese due donne, ancora in prigione dopo più di 40 anni dall’arresto per atti di violenza commessi durante la loro lotta di liberazione. L’anno prossimo, il condannato che sta scontando la pena da più tempo, Romaine “Chip” Fitzgerald, sarà stato incarcerato per mezzo secolo. Il più anziano, Sundiata Acoli, ha 81 anni.
Dal 2000, altri dieci estremisti sono morti in prigione per malattia.
I 19 estremisti attualmente incarcerati facevano tutti parte del movimento rivoluzionario delle Black Panther. Hanno combattuto per il Potere Nero, sono stati condannati per aver ucciso in suo nome, anche se molti di loro si professano innocenti, e oggi sono ancora in prigione per causa sua.
Mentre invecchiano, e la pena si allunga, lo scontro etico su che cosa fare di questi uomini e donne si fa sempre più intenso. La settimana scorsa si era verificato uno sviluppo inatteso, che avevamo segnalato in anteprima; Robert Seth Hayes, ex membro, come Muntaqim, delle Black Panther e del Black Liberation Army, era stato rilasciato, all’età di 69 anni, dallo stesso carcere di massima sicurezza di New York.
Hayes aveva trascorso 45 anni in prigione per l’omicidio di un agente della New York City Transit Police, Sidney Thompson, durante uno scontro avvenuto nella stazione del Bronx nel 1973. Era stato condannato ad una pena variabile da 25 anni all’ergastolo.
Era diventato idoneo alla richiesta di libertà vigilata nel 1998, ma, ogni due anni, si era sentito ripetere sempre la stessa cosa: nonostante fosse un detenuto modello, agli occhi della commissione per la libertà vigilata rimaneva sempre una minaccia per la società. Solo all’undicesimo tentativo, 20 anni dopo, con la salute ormai in rapido declino, era riuscito a convincerli di essere degno della riabilitazione.
Il rilascio di Hayes alza ancora di più la posta in gioco, perché costringe le autorità di New York e quelle di tutto il resto del paese a porsi la domanda cruciale: esiste qualcosa di simile alla riabilitazione per chi ha ucciso agenti di polizia in nome della causa rivoluzionaria del Potere Nero? Bisogna rinunciare alla politica della libertà condizionata basata sul merito? O il sistema giudiziario degli Stati Uniti li ha selezionati per una condanna all’ergastolo estremamente punitiva perché li ritiene prigionieri politici, proprio come si autodefiniscono quegli uomini e quelle donne?
Negli ultimi due anni ho intervistato otto estremisti neri che avevano tutti trascorso lunghi periodi di detenzione. Attraverso visite in carcere, lettere ed email, gli attivisti mi avevano raccontato storie sorprendentemente simili, di come avessero trascorso quasi tutta la loro vita in cella e del lungo cammino verso una libertà che non arriva mai. Sei di essi sono fra i diciannove che, attualmente, sono ancora in carcere.
Uno degli aspetti che colpisce di più nelle loro storie è la costante passione per la causa dell’emancipazione dei neri. La loro convinzione sul valore di questa lotta contro l’ingiustizia è pura e adamantina.
Prendete Jalil Muntaqim, 66 anni. Secondo i termini della sua condanna per duplice omicidio, ha ottenuto il diritto ad essere valutato, ogni due anni, per la libertà condizionata fin dal 2002. Ad agosto ripartirà tutta la trafila: comparirà davanti alla commissione per la libertà vigilata e perorerà la causa del suo rilascio per la nona volta.
Alla commisione parlerà del suo rimorso nei confronti delle famiglie degli agenti uccisi. Parlerà del rimorso che prova verso la sua stessa famiglia, da cui manca ormai da 46 anni.
Ma non rinuncerà al suo credo politico.
Come mi ha detto durante un’intervista di due ore nell’istituto di pena Sullivan, nella zona nord di New York: ”Se ti rendi conto dell’oppressione che ha dovuto subire il popolo nero in questa nazione, nessuno si pentirà mai di essere stato considerato un rivoluzionario. Io non ho nessun rimpianto.”
Le Black Panther, che ufficialmente hanno cessato di esistere nel 1982, sono ritornate nuovamente di moda, postume, negli ultimi due anni. La scena di apertura del film di successo “Black Panther” è stata girata in un campo di pallaccanestro di Oakland, un preciso riferimento al luogo dove era stato fondato il partito nel 1966. La cantante Beyoncé aveva stupito l’America quando, nello spettacolo dell’intermezzo del Super Bowl del 2016, aveva reso omaggio alle Black Panther con un’esibizione comprendente giacche di pelle, berretti e pugni alzati.
Dietro questa parvenza di interesse popolare per le Black Panther, non esiste in pratica un dibattito pubblico su questa rivolta degli anni ‘70 e su quello che ne è seguito. Assai scarsa è la comprensione del pubblico su come avessero fatto le Black Panther, originarie di Oakland, ad avere 70 sezioni in tutti gli Stati Uniti, di come avessero affrontato a viso aperto la brutalità poliziesca, tipica dei centri urbani, nei confronti degli Afro-Americani, su come avessero sviluppato un sofisticato programma di aiuti sociali che includeva mense per i poveri ed anche scuole elementari, e come tutto questo avesse scatenato la feroce repressione del governo federale e dell’FBI, che aveva portato a numerosi conflitti a fuoco, incursioni, intercettazioni illegali, gioco sporco e, infine, allo scioglimento del partito nel 1982.
Ancora meno si sa dei molti attivisti delle Black Panther che erano stati imprigionati.
In breve, adesso potrà anche essere di moda la giacchetta di pelle delle Black Panther, ma c’è veramente uno scarsissimo interesse per le uniformi da carcerato degli ex-attivisti ancora dietro le sbarre.
 Le Black Panther manifestano davanti al tribunale di New York City nel 1969.
Le Black Panther manifestano davanti al tribunale di New York City nel 1969.Il viaggio che mi aveva letteralmente immerso nelle vite delle ex-Black Panther in carcere era iniziato nel 2015 con Albert Woodfox, un membro del cosiddetto Angola Three che, all’epoca, deteneva il primato di essere il prigioniero americano ad aver trascorso più tempo in cella d’isolamento. E’ rimasto in segregazione cellulare, quasi senza interruzioni, per 43 anni.
Insieme ad un suo compagno, Herman Wallace, Woodfox aveva fondato una sezione delle Black Panther nell’Angola, il famoso carcere di massima sicurezza in Louisiana, costruito sul terreno di una vecchia piantagione di cotone. Il nome ricorda la nazione africana da cui i proprietari della piantagione facevano arrivare gli schiavi.
Quando Woodfox era stato mandato all’Angola per rapina, nel 1971, la prigione era completamente segregata, con un’ala per i detenuti bianchi ed una separata per quelli afro-americani. I secondini erano esclusivamente bianchi.
Fulgido esempio del legame che unisce la schiavitù e l’incarcerazione di massa dell’era moderna, i prigionieri di colore erano utilizzati come forza lavoro a basso costo. Ogni giono, i detenuti di colore venivano raggruppati, incatenati e portati nei campi intorno al penitenziario, gli stessi campi che un tempo erano appartenuti alla piantagione, e fatti lavorare sotto il sole cocente.
A raccogliere cotone.
Woodfox e Wallace avevano iniziato, tramite la sezione delle Black Panther, ad organizzare gli altri detenuti di colore per indurli a protestare contro questa moderna forma di schiavitù. La cosa non era piaciuta alle autorità della prigione.
Un anno dopo, entrambi erano stati accusati dell’omicidio di un agente di custodia di nome Brent Miller, pugnalato a morte durante una rivolta carceraria. Sulla scena del delitto era stata raccolta una notevole quantità di prove, ma nessuna che potesse incriminarli, compresa un’impronta digitale insanguinata su un muro.
Nonostante ciò, erano stati giudicati colpevoli da una giuria di soli bianchi e condannati all’ergastolo, senza possibilità di libertà vigilata. Subito dopo la sentenza, Woodfox e Wallace erano stati messi in cella di isolamento, dove sarebbero rimasti per altri 40 anni.
Le dichiarazioni rilasciate nel corso degli anni dalle autorità carcerarie dell’Angola avevano chiarito le ragioni di questo trattamento eccezionalmente severo. L’allora direttore dell’Angola, Burl Cain, aveva detto, nel 1995, che aveva posto Woodfox in isolamento perché “stava ancora cercando di diffondere l’ideologia delle Black Panther.” Cain aveva aggiunto che non aveva voluto che il prigioniero fraternizzasse con gli altri “perché avrebbe arruolato i nuovi, giovani detenuti.”
Nel novembre del 2015, subito prima che gli fosse finalmente concessa, all’età di 69 anni, la possibilità di uscire come uomo libero, Woodfox mi aveva scritto. Nella lettera mi descriveva cosa volesse dire passare 43 anni di vita in una cella di 1,8 x 2,7 metri, con solo un giaciglio di cemento, un gabinetto e un lavandino, con una feritoia nella porta metallica in cui far passare il cibo.
Mi aveva scritto di come fosse sopravvissuto, dentro la cella, ai ricorrenti attacchi di claustrofobia: “Per me il problema era capire quando stava per arrivare la crisi. Mi rendevo conto dello spazio e del tempo. I vestiti cominciavano a stringere. Cominciavo a sudare e diventava difficile respirare. Come se l’atmosfera si stringesse intorno a me e mi schiacciasse.”
Mentre Woodfox e Wallace passavano gli anni in isolamento nell’Angola, migliaia di altri giovani afro-americani entravano a far parte del partito delle Black Panther ad Oakland, Los Angeles, Chicago, New York e in tutti gli Stati Uniti. Anche se il partito era stato fondato da due uomini, Huey Newton e Bobby Seale ed aveva un taglio militare che potremmo definire maschilista, numerosi posti di responsabilità erano stati occupati anche dalle donne.
Fra di loro vi erano Afeni Shakur, madre del rapper Tupac Shakur, Elaine Brown, che sarebbe diventata capo del partito dopo la fuga a Cuba di Newton; Assata Shakur, nota come Joanne Chesimard, una leader del Black Liberation Army, anch’essa riparata a Cuba, dove vive tutt’ora in esilio, ancora sulla lista dei terroristi più ricercati dall’FBI.
Il movimento, contrariamente alla sua fama di violenza, dedicava la maggior parte del tempo al lavoro di comunità. Forniva colazioni gratuite ai bambini poveri dei quartieri neri, allestiva scuole e ambulatori medici per chi non poteva accedere al sistema sanitario e pubblicava un suo proprio quotidiano, il Black Panther, al costo di 10 cent., con una tiratura settimanale che era arrivata, nei periodi di punta, a 250.000 copie.
In contrasto con i toni misurati del movimento per i diritti civili di Martin Luther King, le Black Panther si consideravano allineate ai gruppi internazionali rivoluzionari dell’Angola, del Mozambico e del Vietnam. Alle nuove reclute, conosciute come PITS (Panthers-in-Training), veniva fatto studiare il “Libretto Rosso” di Mao e “I dannati della Terra” di Frantz Fanon.
 Membri del partito delle Pantere Nere distribuiscono gratuitamente abiti alla popolazione di New Haven, Connecticut, 1969.
Membri del partito delle Pantere Nere distribuiscono gratuitamente abiti alla popolazione di New Haven, Connecticut, 1969.Nell’ottobre del 1966, Newton aveva riassunto gli obbiettivi del partito in un programma di dieci punti. Comprendeva un appello contro la brutalità della polizia, non dissimile da quanto chiede oggi Black Lives Matter, una istanza per la riforma del sistema giudiziario, che potrebbe benissimo essere quella dell’American Civil Liberties Union, e una richiesta per la piena occupazione, per case decenti e per un buon sistema scolastico che sembra uscita dalla bocca di Bernie Sanders.
A queste richieste relativamente tradizionali era stato sovrapposto un forte sentimento di militanza nera, in contrasto con l’approccio moderato di King o con la radicata politica progressista di oggi. “Vogliamo porre fine alla rapina capitalistica della nostra Comunità Nera”, si leggeva al punto n° 3 e si continuava chiedendo un risarcimento per la schiavitù subita, consistente in due muli e 40 acri di terreno, un chiaro riferimento alla promessa, non mantenuta, fatta dal generale William Sherman di liberare gli schiavi alla fine della guerra civile.
Poi c’era l’enfasi sul militarismo e sulla lotta armata. Anche la struttura stessa dell’organizzazione era una provocazione, configurare il partito come uno stato all’interno dello stato.
 Huey Newton parla alla convention per la fondazione del Partito Popolare Rivoluzionario nel 1970.
Huey Newton parla alla convention per la fondazione del Partito Popolare Rivoluzionario nel 1970.Come dice Mumia Abu-Jamal, una ex-Black Panther, incarcerato per 37 anni per l’omicidio di un agente di polizia di Filadelfia, “Il partito delle Black Panther si comportava come uno stato-ombra, con i suoi ministri, il suo personale in uniforme e i suoi soldati, in feroce opposizione al governo degli Stati Uniti.”
Una delle prime attività del partito era stata la “vigilanza sulla polizia”, durante la quale i suoi membri monitoravano l’attività delle forze dell’ordine nelle vie di Oakland, in un periodo in cui gli attacchi della polizia alla popolazione nera erano un fatto quotidiano. E’ difficile che una cosa del genere possa succedere al giorno d’oggi, ma, allora, quando vedevano agenti di polizia fermare e perquisire giovani Afro-Americani, le Black Panther si avvicinavano e osservavano la scena, facendo volontariamente intravedere le pistole che portavano alla cintura.
Newton aveva studiato le leggi californiane sul possesso delle armi e sapeva che girare armati in pubblico, senza nasconderlo, alla fine degli anni ‘60 era legale. I legislatori dello stato avevano risposto nel 1967 proibendo il “porto libero” e, per celebrare l’evento, più di 20 Black Panther erano entrate impugnando le armi nel Campidoglio di Sacramento durante il dibattito.
La minaccia di una insurrezione armata dei rivoluzionari neri aveva scatenato una dura rappresaglia da parte del governo degli Stati Uniti.
L’allora direttore dell’FBI, J. Edgar Hoover, aveva giurato di spezzare il partito delle Black Panther, che aveva definito “la più grande minaccia alla sicurezza interna della nazione.”
Il programma di sorveglianza segreto Cointelpro era così stato focalizzato sulle Black Panther e tutte le enormi risorse dell’FBI mobilitate contro di loro. In breve tempo, il partito era stato riempito di informatori e di agenti provocatori, che diffondevano false informazioni e seminavano zizzania fra i ranghi.
Gli scontri violenti con la polizia erano diventati frequenti: le forze dell’ordine e i media li chiamavano “Shoot-outs.” Per le Black Panther erano invece “Shoot-ins,” intendendo con questo termine che gli scontri venivano istigati dalle autorità e che facevano parte dei trucchi sporchi del Cointelpro.
Secondo le stesse Black Panther, fra il 1968 e il 1970 si erano verificati 28 scontri armati con la polizia locale o con gli agenti dell’FBI, in cui 19 dei loro avevano perso la vita. Per contro, le forze di polizie consideravano il Black Liberation Army, l’ala clandestina del partito, fondata nel 1970, responsabile dell’omicidio di almeno 13 agenti di polizia.
Era in questo ambiente che Jalil Muntaqim, allora conosciuto con il nome di Anthony Bottom, si era gettato, anima e corpo, quando aveva solo 15 anni. Non era di certo il candidato ideale per la carriera di rivoluzionario nero, dal momento che proveniva da una famiglia benestante di San Jose, con entrambi i genitori che lavoravano e la piscina in giardino.
La madre aveva insegnato ai figli le danze africane e dava molta importanza alla discendenza familiare. Muntaqim era stato attratto da King e dal movimento per i diritti civili, ma si era subito messo alla ricerca di qualcosa di più radicale. Un compagno di scuola era entrato a far parte delle Black Panther e il movimento lo aveva attirato.
“L’idea che uomini neri, armati e preparati, potessero combattere per i diritti del popolo di colore era eccitante, intrigante. Andava ben oltre il movimento per i diritti civili del dr. King. La differenza fra il dr. King e Malcon X era che quest’ultimo aveva posto la nostra lotta in un contesto internazionale,” mi aveva detto.
Muntaqim aveva iniziato vendendo il quotidiano delle Black Panthere dando una mano nelle mense gratuite. Da qui era stato assegnato alla scorta dei leaders di alto profilo che venivano in visita ad Oakland.
Nel 1970, il Black Liberation Army (BLA) costituiva la falange armata del movimento. In quel periodo e fino alla messa al bando ufficiale del partito delle Black Panther, nel 1982, il BLA era stato implicato in una lunga serie di rapine in banca, attentati dinamitardi, evasioni e omicidi di agenti di polizia.
Muntaqim si era arruolato a 18 anni ed era entrato in clandestinità. “Continuavo ad avere una vita pubblica come assistente sociale al Dipartimento per la Disoccupazione della California,” ha spiegato nell’intervista. “Ma c’era un altro aspetto della mia vita: la mia attività clandestina nel Black Liberation Army.”
Il 21 maggio 1971, due agenti di polizia di New York, Joseph Piagentini, bianco, e Waverly Jones, di colore, erano di pattuglia nella 159° Strada, ad Harlem. Erano stati chiamati per quella che sembrava una lite familiare.
Diane Piagentini descrive Joseph come “un gran marito e un gran genitore, che amava le nostre due bambine. Era alto, quasi un metro e ottanta, capelli e occhi scuri. Aveva un gran sorriso, un sorriso dolce e la fossetta nel mento. E’ stato l’amore della mia vita. L’ho amato fin dal primo istante.”
 Gli agenti della polizia di New York, Joseph Piagentini e Waverly Jones, uccisi da Herman Bell ed altri ad Harlem nel 1971.
Gli agenti della polizia di New York, Joseph Piagentini e Waverly Jones, uccisi da Herman Bell ed altri ad Harlem nel 1971.Ricorda come quella notte le era stata data la notizia. “Gli avevo preparato la pasta e fagioli, la tenevo in caldo e aspettavo che tornasse a casa. Avevano bussato alla porta. Avevo guardato fuori e stava piovendo. Vedevo i lampeggianti della polizia che continuavano a roteare. Niente sirene, solo le luci. Era come essere in un sogno.”
Joseph Piagentini e Waverly Jones stavano ritornando all’auto di pattuglia, circa alle 22, quando erano stati attaccati alle spalle da tre uomini armati. Jones era morto subito, colpito da un proiettile alla nuca; Piagentini, secondo gli inquirenti era stato colpito 13 volte.
Nel giro di pochi giorni erano stati arrestati tre membri del BLA, Muntaqim, Herman Bell e Albert “Nuh” Washington. Muntaqin e Bell erano stati entrambi condannati ad un periodo di detenzione non inferiore a 25 anni, Washington è morto in prigione nel 2000.
Tre mesi fa si è verificato un evento raro: Herman Bell, 70 anni di età, è stato rilasciato. Era stata la sua ottava apparizione di fronte alla commissione, dopo 45 anni dietro le sbarre.
Bell era apparso alla commissione per la libertà vigilata come qualcuno che, dopo quasi mezzo secolo, era diventato un detenuto modello e provava un sincero rimorso per i suoi omicidi. Una parte della decisione del comitato era dovuta al fatto che, quando era stato interrogato nel mese di marzo, Bell aveva espresso il proprio disgusto per quello che aveva commesso nel 1971.
“Non c’era niente di politico in quel gesto, come pensavo all’epoca. Si è trattato di omicidio, un omicidio terribilmente sbagliato,” aveva detto loro Bell.
La decisione della commissione ha scatenato un vespaio di proteste da parte dei sindacati locali di polizia, dei media e degli esponenti politici. La New York Patrolmen’s Benevolent Association ha dichiarato di essere “disgustata, offesa ed estremamente adirata” ed ha definito Bell “un terrorista locale.”
 Diane Piagentini nella sua casa.
Diane Piagentini nella sua casa.Una tale reazione al rilascio sulla parola del suo coimputato fa capire la grande sfida che Muntaqim si troverà a dover affrontare quando si troverà di fronte alla commissione, nel mese di agosto.
A suo favore gioca il comportamento da detenuto modello che ha tenuto per anni. La stessa cosa si può dire riguardo alla maturazione del suo carattere, dai giorni della sua attività rivoluzionaria in gioventù.
“Sono maturato. Ora tolgo la ‘r’ da quella parola e la faccio diventare ‘evoluzione’. Per me la rivoluzione è il processo evolutivo con cui raggiungere un più alto livello di coscienza nella società in generale. Mi ritengo un rivoluzionario evoluzionista.”
Mi ha anche detto che si è evoluto anche il suo concetto di lotta armata. Secondo lui la priorità non dev’essere l’insurrezione, ma la costruzione di “un movimento popolare di massa. Preferisco dire che siamo armati di idee, di comprensione e di amore per il nostro popolo.”
Come la maggior parte degli altri diciannove estremisti di colore attualmente detenuti, si considera un prigioniero politico e afferma che la sua militanza nelle Black Panther non era dovuta all’autoesaltazione o al profitto personale. Nel 1998, aveva fondato il Movimento Jericho, che si batte per tutti quelli che vengono definiti “prigionieri politici e prigionieri di guerra.”
“Il mio impegno alla lotta è stato un auto-sacrificio, causato dall’amore per la mia gente e per l’umanità. Per questo motivo sono stato preso di mira dal governo e ciò fa capire che la mia detenzione è di natura politica.”
Il conflitto che attanaglia Muntaqin, il suo ardente desiderio di libertà opposto alla volontà di non rinunciare al proprio credo politico, da lui ritenuto nobile, è condiviso dalla maggior parte degli altri diciannove estremisti di colore che ancora si trovano dietro le sbarre.
Di questi diciannove, sedici erano stati condannati per l’assassinio di agenti di polizia o di altri funzionari in divisa. Molti di loro dicono di essere innocenti e la maggior parte sostiene di essere stata appositamente selezionata per subire la collera dello stato americano.
Che cos’ha in comune il loro trattamento con quello riservato agli altri detenuti colpevoli dell’assassinio di agenti delle forze dell’ordine nel corso di reati comuni, come, per esempio, le rapine? Un confronto significativo è impossibile, vista la natura decentrata del sistema giudiziario americano. Come sottolinea il Sentencing Project: “I 50 stati usano metodiche differenti nel comminare le pene. Dal momento che i casi politici sono relativamente pochi, è difficile arrivare a delle conclusioni concrete.”
Le comparazioni internazionali sono comunque istruttive. In confronto al trattamento carcerario dei rivoluzionari armati che si erano macchiati di crimini violenti in Europa negli anni ‘70, gli Stati Uniti sembrano essere molto meno aperti al concetto di riabilitazione.
Prendete la Banda Baader-Meinhof della Germania Occidentale, il gruppo di estrema sinistra fondato nel 1970, conosciuto anche come Rote Armee Fraktion. Imgard Moller, che era stata arrestata nel 1972 per un attentato dinamitardo che aveva ferito diversi agenti di polizia e ucciso tre soldati, è stata rilasciata nel 1995. Anche Brigitte Mohnhaupt, che era stata catturata nel 1982 e condannata a cinque ergastoli per la sua partecipazione a numerosi omicidi, è stata rilasciata nel 2007, dopo 24 anni di detenzione, e da allora vive in modo anonimo, senza più obblighi verso la giustizia.
Chi si batte per la riforma del sistema giudiziario americano sostiene che i lunghissimi periodi di detenzione comminati agli estremisti del potere nero devono essere visti nel contesto dell’eccezionalmente severo concetto di punizione dell’America, specialmente nei confronti della gente di colore. Gli Stati Uniti, con il 5% della popolazione mondiale, ospitano il 25% dei detenuti di tutto il mondo, con più di due milioni di persone incarcerate. In America, una persona di colore ha una probabilità sei volte maggiore di essere imprigionata rispetto ad un bianco. Nel 2016, secondo il Pew Research Center, la popolazione di colore rappresentava solo il 12% della popolazione adulta degli Stati Uniti, ma il 33% di quella carceraria. La popolazione bianca, al contrario, costituiva il 64% degli adulti americani, ma contribuiva a quella carceraria solo per il 30%.
La folta rappresentanza dei detenuti americani sta anche invecchiando rapidamente. Secondo alcune stime, nel 2030 le persone di 50 o più anni costituiranno un terzo di tutta la popolazione carceraria dagli Stati Uniti.
“E’ un problema di giustizia e riabilitazione,” dice Robert Boyle, che ha rappresentato sei ex-Black Panther, compreso Herman Bell, durante le valutazioni per la concessione della libertà condizionata. Si è rifiutato di discutere il caso di Bell, ma, parlando in generale, ha detto: “E’ un problema che dobbiamo affrontare, in questo paese e in tutto il mondo. E’ forse l’unica forma di giustizia uccidere o far morire in carcere il colpevole dell’assassinio di un agente di polizia o di qualche altro efferato crimine, anche quando non rappresenta più nessun pericolo per il pubblico?”
La scrittrice ed attivista Angela Davis, che era stata definita dal Presidente Richard Nixon una “pericolosa terrorista” dopo essere stata accusata (e poi assolta) di complicità nel rapimento di un giudice, mi ha detto che gli attivisti neri attualmente detenuti sono in un vicolo cieco. O si pentono di crimini che non hanno mai commesso, o moriranno nelle loro celle.
“Molte delle persone attualmente in carcere, io credo, non sono assolutamente colpevoli di ciò di cui vengono accusate. Dovrebbero confessare di essere state implicate in eventi a cui però non avevano partecipato.”
La Davis mi ha detto che i militanti sono stati anche sottoposti a pressioni per indurli a tradire il proprio credo politico. “Dovrebbero denunciare un partito che è stato il precursore del Black Lives Matter di oggi.”
Quando Jalil Muntaqim, fra qualche giorno, si troverà di fronte alla commissione per la libertà vigilata, è quasi certo che si sentirà chiedere spiegazioni su quello che era successo nella notte del 21 maggio 1971. Io, quando l’ho incontrato in prigione, gli ho rivolto la stessa domanda.
E’ tuttora dell’opinione che il suo caso non sia stato trattato nella maniera giusta. In base alle leggi sulla libertà di informazione ha potuto avere accesso a documenti che mostrano come Nixon ed Hoover avessero manifestato un interesse personale per la caccia ai responsabili dell’omicidio (da essi chiamato “Newkill”, New York killings) dei due agenti di polizia di New York. Quella insolita collaborazione fra Casa Bianca, FBI e investigatori locali non era mai stata comunicata, come avrebbe dovuto essere, agli avvocati difensori di Muntaqim durante il processo.
Muntaquim è anche del parere che quei documenti indichino palesi discrepanze nelle prove fornite alla giuria sulle le armi usate negli omicidi.
Sta forse dicendo che ai più alti livelli c’era il desiderio di addossargli gli omicidi di Piagentini e Jones?
“Lo dico con convinzione. Il caso era una trappola. E’ importante che la gente capisca che noi non abbiamo avuto un processo equo. Nixon e l’FBI volevano essere certi che fossero condannati per questo reato dei membri del partito delle Black Panther.”
Nonostante le ingiustizie che dice di aver sofferto, Montaquim non si proclama innocente. Fin dal 2006 ha continuato a ripetere ogni due anni alla commissione per la libertà vigilata che si assume in pieno la responsabilità degli omicidi e che “mi pento moltissimo per aver causato quelle due tragiche morti.”
Mi ha detto: “Ho ammesso la paternità di quel gesto e ne ho assunto la piena responsabilità. Ho anche espresso rimorso per la perdita di vite umane. Capisco la sofferenza che prova chi perde una persona amata. Entrambe le famiglie, i Jones e i Piagentini, hanno perso qualcuno di molto caro.”
Se gli fosse concessa la libertà, dice che il suo obbiettivo sarebbe quello di “ristabilire i rapporti con la mia famiglia. Non ho mai passato un giorno di libertà con mia figlia. Sono un bisnonno e non sono mai stato con nessuno dei miei ragazzi.”
Ha un messaggio diretto per Diane Pigentini: “Capisco il suo dolore. Ha perso l’amore della sua vita e il padre dei suoi figli. Questo è devastante. Capisco la sua sofferenza e il suo dolore, veramente.”
La Piagentini non vuole neanche sentirne parlare. Secondo lei, Muntaqim “non ha mai ammesso di avere ucciso mio marito. Non ha mai mostrato rimorso. Tutto quello che fa, lo fa per cercare di uscire di prigione.”
Sulla morte di suo marito, quasi 47 anni fa, dice: “Il dolore non passa mai. Sapere che non farà mai più ritorno a casa, non me ne fa provare di meno. Non voleva lasciarmi quella notte, e perciò è come se non mi avesse mai lasciato.”
Si mette a ridere all’idea che Muntaqim e i suoi complici siano dei prigionieri politici. “Questi uomini non sono prigionieri politici, è frutto della loro immaginazione. Se avessero voluto entrare in politica non avrebbero dovuto fare quello che hanno fatto. Non c’è nessuna guerra. Quello è stato un omicidio. Quelli sono degli assassini.”
 Antoinette Russell
Antoinette RussellIn Alabama, Antoinette Russell non può fare a meno di essere sui carboni ardenti per l’imminente comparsa del padre davanti alla commissione per la libertà vigilata, nonostante tutti i suoi sforzi per non farsi coinvolgere dal processo. E’ la sua unica figlia, nata sei mesi dopo il suo arresto. Pensa di averlo visto, di persona, non più di una decina di volte in tutta la sua vita, sempre al di là di una barriera di filo spinato percorso da corrente elettrica.
Ripensa alla sua vita e si chiede come sarebbe stata se il padre non fosse entrato a far parte delle Black Panther. “Crescere senza mio papà ha avuto un sacco di alti e bassi, più bassi che alti,” mi dice.
“Quando ero più giovane ero veramente arrabbiata nei confronti di mio padre. Ero convinta che avesse preferito la causa a me, alla sua famiglia.”
Nel corso degli anni lo ha perdonato. Ma il desiderio di riaverlo a casa non ha fatto altro che crescere.
“Le prigioni, non dovrebbero servire a riabilitare?” chiede con una risata amara. “C’è stato per 46 anni. Quanto tempo ci vuole per essere riabilitati?”
Ed Pilkington
Fonte: theguardian.com
Link: https://www.theguardian.com/us-news/2018/jul/30/black-panthers-prison-interviews-african-american-activism
30.07.2018
Tradotto da Markus per comedonchisciotte.org

Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM